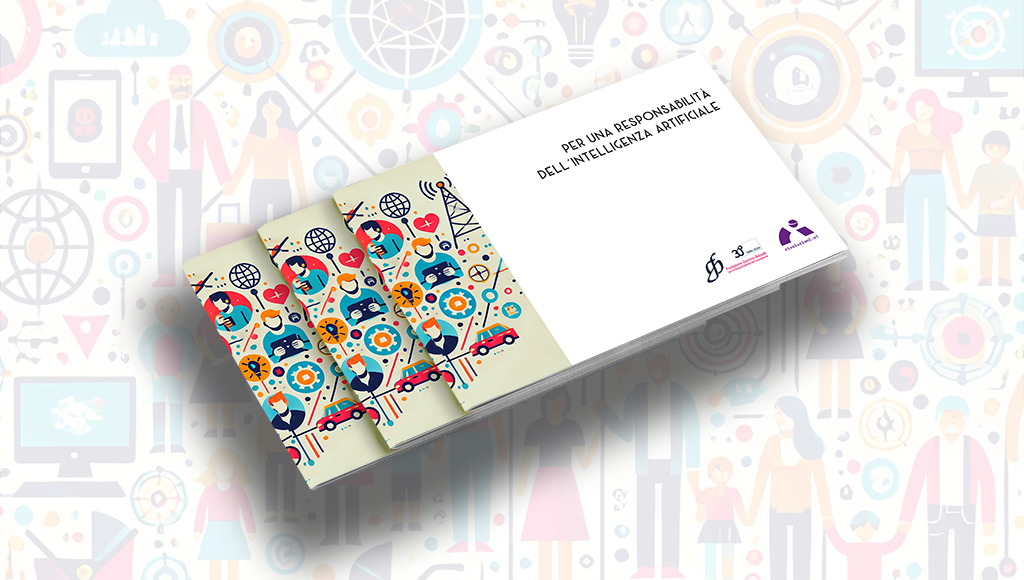SCARICA DA QUESTO LINK IL PAPER “PER UNA RESPONSABILITA’ DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE”
Un Libro Bianco sull’intelligenza artificiale sta coerentemente nella missione di Fondazione Bassetti. Ci sta doppiamente se, come si legge nella prefazione del presidente Piero Bassetti, l’intelligenza artificiale investe da un lato questioni che riguardano il “sapere” e, per usare le sue parole “non tanto un problema di più sapere, quanto di diverso sapere” – e dall’altro lato investe le questioni di “potere”, dalla necessità, per quanto ideale, di nuove norme e diritti, ai nuovi e diversi bisogni che riguardano la formazione, il farsi conoscenza e cittadinanza.
Lo sguardo di Fondazione su ciò che molti hanno definito un cambiamento d’epoca, non poteva quindi essere ridotto all’elencazione delle potenzialità, delle capacità, dei primati, delle aspettative intorno all’intelligenza artificiale; a una rincorsa di annunci superati nel giro di poche settimane o giorni. L’intento è se mai quello di riflettere su come, l’introduzione di questa nuova tecnologia, si manifesta nella natura e nelle scelte di chi la usa, che sia nella dimensione pubblica o privata. Non è tanto l’intelligenza artificiale in sé, insomma, quanto questa dice di noi.
Come attrezzarci a questa trasformazione? Quale preparazione, postura intellettuale e valoriale, per rispondere alle sollecitazioni di questo tempo? Cosa serve, in definitiva, per non passare dalla “delega” a una totale rinuncia di potere, a una sorta di abdicazione in piena regola anche alle nostre responsabilità? Sono queste le domande sottese ai pensieri raccolti nel libro bianco. E non a caso il primo capitolo riguarda la Responsabilità e delega dei processi decisionali, sia con un accenno ai rischi che corriamo delegando all’intelligenza artificiale i processi decisionali, per esempio, nella concessione di assicurazioni o assistenza sanitaria; sia mostrando le potenzialità che potrebbe avere l’adozione dell’intelligenza artificiale come supporto ai processi di democrazia partecipativa.
La connessione tra sfera pubblica e privata si ritrova nel secondo capitolo Oltre il corpo e la mente. Le implicazioni etiche generate dal passaggio dalla neurotecnologia alla personal neurotech richiedono infatti un ripensamento dell’importanza etico-giuridica del cervello. Sono i nuovi neurodiritti, oggetto di diversi seminari organizzati dalla Fondazione a cui sono intervenuti da Andrea Lavazza a Marcello Ienca, accogliendo quindi le istanze più sensibili e illuminate sul tema. Ma è anche la presa di coscienza che quello che stiamo vivendo è la dissoluzione dei confini tra mentale e sociale, tra psichico e politico: tutte le relazioni sociali si sono psicologizzate, mentre il privato è definitivamente entrato nel discorso pubblico. Interferire con il cervello significa allora interferire con tutte le funzioni che ci definiscono come esseri umani, incrociando quei diritti, come la libertà di parola, libertà cognitiva, il diritto alla privacy mentale, all’integrità mentale, che non sono che esternalizzazioni dell’attività cerebrale.
Fondazione Bassetti rinnova così la sua vocazione a spingersi oltre il consueto, oltre lo specchio direbbe Piero Bassetti. Oltre il corpo, ma anche oltre la scansione generazionale (capitolo 5), oltre a ciò che convenzionalmente o pragmaticamente, interessa come vita, estendendo la datificazione da prima della nascita (Barassi e Mascheroni sono intervenute più volte sul tema) al dopo morte, perché anche in questa dimensione emerge un’assenza di linee guida etiche specifiche.
Una parte del libro bianco raccoglie I Dialoghi su Responsabilità e Intelligenza Artificiale presenti nel sito. Una sorta di tavola rotonda virtuale, ma anche un tentativo di trovare un racconto diverso rispetto a una narrazione sull’intelligenza artificiale che sembra esaltare il mito prometeico del cambiamento rapido e totalizzante. E anche una comunicazione, intesa come distribuzione sociale delle informazioni, più umana, che si orienti maggiormente nella ricerca di un senso all’interno di una memoria collettiva o della relazione, come hanno suggerito Fabio Grigenti o Mauro Magatti. Una comunicazione in cui, come è logico, c’è una quota di responsabilità.
Ovviamente il Libro Bianco Per una responsabilità dell’intelligenza artificiale non vuole mettere un punto. Se mai è un primo tentativo di strutturare una conversazione che all’interno di Fondazione stava diventando sempre più complessa, accogliendo contributi da associazione vicine come rivoluzioni.ai, e aprendo ad altri ambiti come quello legati alle pratiche artistiche e creative.
Di seguito l’INDICE del libro bianco:
Prefazione La responsabilità di disporre di un diverso sapere.
di Piero Bassetti
Capitolo 1 Il monopolio delle intelligenze. Responsabilità e delega dei processi decisionali.
Le cose sono di due mani, alcune in poter nostro, altre no | di Francesco Samorè
Se l’IA se la prende con i deboli. Il report di TechTonic Justice | di Marta Abbà
Uno strumento per la democrazia partecipativa tra globale e locale | di Manuela Mimosa Ravasio
Capitolo 2 Oltre il corpo e la mente.
Un habeas mentem per proteggere la libertà nel mondo digitale | di Gabriele Giacomini
Con la forza del pensiero. I nuovi neurodiritti
Neurodiritti. Un parametro della cittadinanza europea che si affaccia | di Francesco Samorè
Capitolo 3
Dialoghi su Responsabilità e Intelligenza artificiale.
a cura di Manuela Mimosa Ravasio
Introduzione
Guido Boella. L’intelligenza artificiale cambia il perno dell’etica
Fosca Giannotti. Per un’intelligenza artificiale trasparente
Donata Columbro. Dati più umani per algoritmi più equi
Andrea Gaggioli. Intelligenza artificiale, processi cognitivi e nuove dimensioni
Marta Bertolaso. Una filosofia della vulnerabilità e della cura per affrontare l’IA
Mauro Magatti. Un immaginario al di là dell’innovazione tecnologica
Fabio Grigenti. Dalla Grecia a Kant, la via europea a una società (etica) dei dati
Francesca Buffa. Il futuro della ricerca è nell’integrazione dei dati biometrici
Elena Esposito. Comunicazione artificiale. Quando il dialogo è con un algoritmo
Capitolo 4
Follow the money. Quanto (ci) costa l’IA generativa.
a cura di rivoluzioni.ai
Introduzione
Panoramica con grafici
Capitolo 5
Generazioni e innovazioni. Intelligenza artificiale e transizione demografica.
Le cinque (ri)generazioni: (r)innovarci responsabilmente | di Francesco Samorè
Una finestra sul Giappone | di Stefania Bandini
L’età genetica | di Elisa Mariani
Capitolo 6
Salute, diritti, vita: questione di dati.
Infanzie datificate
Lo spazio europeo dei dati sanitari
Deadbot: l’illusione dell’immortalità digitale | di Mara Colombo
Capitolo 7
L’avanzata del metaverso.
Nel metaverso per dialogare | di Tommaso Correale Santacroce
Il lato umano del metaverso. Dialogo con Marco Centorrino e Josephine Condemi | di Marta Abbà
Tecnologie estese. Come cambia l’esperienza educativa | Intervista di Manuela Mimosa Ravasio a Sabina Bartolotta
Capitolo 8
Arte, responsabilità e industria creativa.
Introduzione
Rivoluzionare la creazione musicale con l’intelligenza artificiale | di Luca Severino