Il 10 giugno 2025, Fondazione Bassetti ha organizzato un seminario in occasione della pubblicazione del nuovo libro di Gabriele Giacomini edito da La Nave di Teseo Il trilemma della libertà: Stati, cittadini e compagnie digitali. Oltre all’autore, e alla presenza del presidente Piero Bassetti, hanno partecipato alla discussione Eleonora Barelli, Sabrina Bartolotta, Lucia Dal Negro, Gabriele Scafati, Ludovica Taurisano e Francesco Samorè. Un breve intervento è stato riservato alla presentazione del libro bianco di Fondazione Per una responsabilità dell’intelligenza artificiale (qui il link per l’approfondimento e il libero download).
In questa pagina, oltre alla sintesi a cura di Manuela Ravasio, potete accedere alle riprese video, ai podcast e alle fotografie dell’intero incontro.
«Quello che ho cercato di fare nel mio libro è di unire a un’analisi informata di ciò che accade, un ideale che cerca comunque di misurarsi con la realtà e un tempo di massima accelerazione e rincorsa tecnologica. Rigettando una versione ecumenista della tecnologia, quella degli “apocalittici e integrati” di Umberto Eco per intenderci, ho provato a descrivere i diversi assetti determinati dai diversi rapporti tra stati, cittadini e compagnie digitali. E il trilemma non sta tanto nella presenza dei tre attori elencati, quanto nel tramonto di quella visione dualistica e contrapposta, e soprattutto nel mutamento della nostra libertà quando mutano le condizioni e le alleanze di cui sopra». È lo stesso Gabriele Giacomini a riassumere la riflessione cardine del suo libro. Lo fa quasi a conclusione di una discussione in cui gli stimoli offerti dagli interventi di relatrici e relatori hanno esplorato le connessioni più diverse dei termini sul tavolo.
La libertà, innanzi tutto. Perché se, come dice Giacomini, «la libertà è essenzialmente una forma di potere, evidenziando come il tema della libertà e quello del potere siano intrecciati tra loro anche in questo libro», l’invito di Francesco Samorè all’inizio del seminario è proprio quello di «spostare il centro di interesse dalla libertà al potere, e vedere come stati, cittadini, compagnie digitali fanno gioco sul grande interrogativo che è la relazione tra il sapere, un sapere oggi nutrito di tecnoscienza, innovazione, intelligenze artificiali, e il potere, relazione che è poi uno dei temi cari alla nostra Fondazione. Insieme ovviamente a quello di chi governa il potere. Era il 1959 quando il presidente scrisse Le redini del potere insieme a Giacomo Corna Pellegrini, e oggi bisogna rilevare che con il mutare delle forme del potere, è cambiato anche l’animale che dobbiamo cavalcare, ponendo sfide non solo normative, ma anche di senso, se questo stesso animale si nutre di una quantità di dati che è diventata qualità, e che diventa comportamento, linguaggio, e persino pensiero spostandosi da forme di potere agite sul corpo a forme di potere che investono anche la mente». «Chi controlla i dati ha un potere enorme» afferma Gabriele Scafati, «tanto che a livello normativo sono stati disciplinati in modo strutturato ed europeo con il GDPR, e AI Act proprio per evitare la concentrazione del loro controllo e conseguente manipolazione. L’obiettivo fondamentale è sempre quello di garantire in qualche modo l’autodeterminazione dell’individuo».
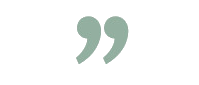
Bisogna (...) chiedersi che tipo di Stato abbiamo di fronte. Uno Stato democratico, una cleptocrazia, una tecnocrazia? Dipende dagli assetti del trilemma
Quindi lo Stato. Perché quando potere e Stato non sono più coincidenti, o almeno la forma dello Stato così come la conosciamo non riesce a cavalcare la velocità delle innovazioni, «il trilemma della libertà non ha più niente a che fare con la statualità, perché quello che è veramente in crisi di fronte alla libertà o alla sua negazione è lo Stato in quanto participio passato del verbo essere, nella sua funzione normativa e regolatoria capace di stare dietro al cambiamento», afferma Piero Bassetti. Della “crisi della statualità” dà una sua lettura anche Ludovica Taurisano: «Lo Stato non ha più alcun tipo di credibilità e di autorevolezza perché, con l’avvento delle guerre ibride, ha perso il monopolio del potere della violenza fisica; ha perso, con Big Tech che hanno un fatturato più grande del Pil di molti Paesi, il monopolio del potere economico; e ha perso anche il monopolio del potere simbolico, se ormai è la tecnologia a disegnare immaginari e aspirazioni». Di altro avviso è l’autore del libro: «Lo Stato non è affatto tramontato e sta riemergendo con forza parallelamente a una crisi della globalizzazione. Nulla di strano, la storia ha visto la fine della globalizzazione romana, della regionale basata sul Mar Mediterraneo, la globalizzazione inglese… ma lo Stato c’è. Certo, è in crisi, si potrebbe dire che è una copertura per poteri altri, che è stressato da elementi come la rapidità dei cambiamenti, la fine dei suoi monopoli, non ultimo dall’evoluzione della statistica, la scienza dello Stato, perché nel momento in cui tu gestisci i dati dei cittadini hai un potere che deriva dal sapere, ma oggi, proprio in virtù del trilemma spiegato nel libro, alcuni poteri caratteristici dello Stato si stanno trasferendo alle compagnie digitali. Bisogna, se mai, chiedersi che tipo di Stato abbiamo di fronte. Uno Stato democratico, una cleptocrazia, una tecnocrazia? Dipende dagli assetti del trilemma: in un assetto di libertà soffocata in cui Stati e compagnie digitali si alleano contro i cittadini lo Stato è autoritario, come in Ungheria o Turchia. L’alleanza tra cittadini e compagnie digitali contro gli Stati determina invece lo Stato cleptocratico, che per esempio utilizza Cambridge Analytica per manipolare la popolazione… la democrazia resiste in altri assetti, ma non è più scontata. Il migliore degli assetti a cui penso, vede i cittadini che si organizzano attraverso lo Stato, e informano in senso valoriale anche la tecnologia attraverso le compagnie digitali: un ideale tanto più importante quanto più difficile da raggiungere».
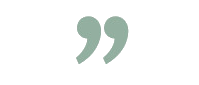
Pensare (...) alla tecnologia come unico driver, unico fattore trasformativo, ci fa schiacciare l’immaginazione su alcune traiettorie definite
Ma quale ruolo, potere, consapevolezza, i cittadini (e cittadine) agiscono all’interno del trilemma? Eleonora Barelli pone una questione non secondaria: «Associare il futuro al colore blu della tecnologia è un’equazione difficile da sciogliere, e nello stesso tempo urgente da affrontare. Pensare infatti alla tecnologia come unico driver, unico fattore trasformativo, ci fa schiacciare l’immaginazione su alcune traiettorie definite. E invece non esiste un futuro, ma, stando proprio alla complessità del trilemma suggerito da libro, molti futuri più o meno desiderabili di altri, e desiderabili se visti da prospettive diverse». Il riferimento all’impatto di questa dimensione simbolica sui comportamenti sociali, ma anche sulla literacy legata all’intelligenza artificiale e alle trasformazioni indotte, è affrontato da Sabrina Bartolotta, che ricorda la presenza, all’interno di università come Stanford di Symbolic System Program, laboratori di sistemi simbolici che producono ricercatori e imprenditori che si occupano di creare la narrazione del simbolismo rispetto alla tecnologia, visioni distopiche comprese. Quando la narrazione si trasforma in manipolazione narrativa, ci troviamo invece in contesti come quelli riportati da Lucia Dal Negro che, nel periodo Covid, ha vissuto in prima persona il tipo di falsificazione delle informazioni che hanno subito le popolazioni dei Paesi dell’Africa subsahariana: «In contesti di povertà molto estesa, è ben visibile l’estremo potenziale a cui arrivano quelli che nel libro di Giacomini vengono definiti “gli ingegneri della manipolazione”. Fatti non soltanto falsi, ma fatti deliberatamente falsificati per ritagliare concetti ad hoc per cittadini particolari. Per chi ha studiato economia dello sviluppo e relazioni internazionali, è un po’ lo sgretolamento del capability approach di Amartya Sen: i cittadini possono accedere a un effettivo sviluppo, qui diremmo possono avere un potere effettivo, quando non solo si trovano nella disponibilità e possibilità di averlo, ma anche possiedono l’effettiva capacità di scegliere l’opzione desiderata».
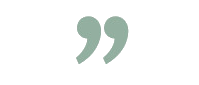
una frammentazione e polarizzazione per cui la società stessa non esiste più, esistono soltanto i cittadini
Non è un caso, dunque, nelle battute finali del seminario, il tema costante che emerge dalle variabili del trilemma è quello di “un’opinione pubblica veramente costituita” (Taurisano), di un “darsi ed esercitare un permesso emancipato dalle istituzioni” (Bartolotta), di una partecipazione fatta di corporeità. «Negli ultimi decenni la partecipazione è in chiara difficoltà» conclude Giacomini. «I motivi sono molti, e vanno dalle echo chamber alle virtual bubble, dalla difficoltà di organizzarsi in contesti sempre più precari, fino a un individualismo e una frammentazione e polarizzazione per cui la società stessa non esiste più, esistono soltanto i cittadini. Albert Hirschman diceva che noi oscilliamo fra felicità pubblica e felicità privata; il nostro senso di benessere, il nostro sistema valoriale, oscilla fra un livello pubblico e uno privato. Ci sono dei momenti della storia in cui prevale il pubblico, e allora siamo nell’età dell’oro della democrazia. E ci sono fasi in cui invece, come effetto secondario di questa felicità pubblica, ci si orienta verso una felicità privata in cui è difficile vedere i problemi come collettivi. È questo il momento in cui è difficilissimo organizzarsi e la partecipazione cede. Ed è questo il momento in cui anche la tecnologia si disallinea dal benessere collettivo. Secondo Hirschman, a un certo punto gli effetti della felicità privata cominciano a essere così costosi da un punto di vista sociale, che le persone si riorientano verso la felicità pubblica. Se sarà questo l’assetto del futuro, lo vedremo fra dieci o vent’anni».
Il commento di Piero Bassetti
Premesso che per avere una risposta sul potere, dovremmo avere qualche idea sull’Oltre, quello che a me ha impressionato nella discussione è l’accettazione, il determinismo di tutti i discorsi. La libertà contiene uno spazio, che per comodità chiamiamo “di sogno”, che la scienza non contiene e che evidentemente l’innovazione non contiene. La Fondazione Bassetti campa su questo: cioè l’idea, che era vera e valida trent’anni fa, che l’innovazione non è un bene in sé, ma è tale perché va “oltre”, postula cioè il giudizio sull’Oltre, sul perché si è andati oltre i limiti consueti. Io sono rimasto impressionato, se posso dirlo, dalla irresponsabilità di fondo che c’era in tutti i contributi critici, non sentendo alcun giudizio di valore, benché generico, sulle fattispecie che si delineano per effetto delle circostanze più diverse. L’impressione è stata quella di un gruppo di intelligenze eterodeterminate, con una maggioranza di donne negli interventi, per le quali in modo particolare c’era l’interesse al cambiamento piuttosto che al senso del cambiamento. In effetti, credo che effettivamente questo sia lo stesso problema dello Stato: l’accettazione acritica di una responsabilità comune è una componente storica da cui non si può prescindere. Si può dire infatti che lo Stato è morto, ma l’idea dello Stato, cioè l’idea di un organizzatore portatore di potere comune, è di fatto insostituibile. Io ho interpretato il libro, e il trilemma, come il trilemma di tre statualità. Il che è interessante, diciamo così, perché la sua interpretazione passa da uno Stato che non dovrebbe esserci a uno Stato che si moltiplica, che fa per tre.



















