Conflict of Interest in Science

|
Chiusura del Percorso [25
marzo 2002]
All'inizio di questo Percorso si è scritto che «il "conflitto di
interesse" di cui parliamo si verifica quando un ricercatore, uno scienziato,
ha una qualche forma di interesse finanziario nel campo di studi di cui si occupa». I
documenti e gli articoli raccolti, oltre a esemplificarne la diffusione nella pratica
scientifica, evidenziano pure come la questione del "conflitto di interesse" sia
ormai all'attenzione della comunità scientifica, all'interno della quale si sono levate
le voci critiche. (25 marzo 2002 - V. Bertolini) |

![]() Philip Campbell, direttore di Nature, ha aperto il numero del 23 agosto con la nuova
politica editoriale: gli autori degli articoli vengono incoraggiati a dichiarare ogni
interesse finanziario che possa essere posto in relazione con la ricerca da loro svolta.
Philip Campbell, direttore di Nature, ha aperto il numero del 23 agosto con la nuova
politica editoriale: gli autori degli articoli vengono incoraggiati a dichiarare ogni
interesse finanziario che possa essere posto in relazione con la ricerca da loro svolta.
«(...) For the purposes of this statement, competing interests are defined as those of a financial nature that, through their potential influence on behaviour or content or from perception of such potential influences, could undermine the objectivity, integrity or perceived value of a publication. They may include any of the following:
• Funding: Research support (including salaries, equipment, supplies, reimbursement for attending symposia, and other expenses) by organizations that may gain or lose financially through publication of the paper.
• Employment: Recent (that is, while engaged in the research project), present or anticipated employment by any organization that may gain or lose financially through publication of the paper.
• Personal financial interests: Stocks or shares in companies that may gain or lose financially through publication; consultation fees or other forms of remuneration from organizations that may gain or lose financially; patents or patent applications whose value may be affected by publication. (...)»
"Introducing a new policy for authors of research papers in Nature and Nature
journals", l'editoriale scritto da Campbell, rappresenta quindi un passo
significativo, messo in atto da una prestigiosa rivista scientifica, che recepisce, nella
forma dell'auto-regolamentazione, il senso e la portata del recente movimento di opinione
volto a sensibilizzare in merito al problema del conflitto di interesse in ambito
scientifico.
![]() Si veda, a riguardo, l'editoriale
del numero di maggio-giugno di Psychotherapy and Psychosomatics [in
English] (sotto, in questa pagina)
Si veda, a riguardo, l'editoriale
del numero di maggio-giugno di Psychotherapy and Psychosomatics [in
English] (sotto, in questa pagina)
![]() "Rassegna
stampa commentata
"Rassegna
stampa commentata
«(...) La pratica scientifica non è sempre o solo competizione fra teorie ma anche (o soprattutto) fra ricercatori per accaparrarsi fondi, fama, prestigio, visibilità sociale ecc. Tutto ciò, unitamente al fatto che la ricerca scientifica e le sue applicazioni è sempre più coinvolta in processi commerciali, comporta un coinvolgimento anche economico: ad esempio, possedere azioni di un'azienda direttamente interessata a un particolare risultato, esserne consulenti, aver ricevuto finanziamenti di qualsiasi tipo e via dicendo. (...)»
«(...) Il problema del conflitto di interessi nell'ambito della ricerca scientifica ci induce a chiederci se un ricercatore che esce dal laboratorio e utilizza la sua qualificazione professionale in un ambito pubblico --consulente governativo, componente di un comitato etico, redattore di una pubblicazione specializzata, o più semplicemente, opinionista della stampa quotidiana-- sia, come la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto.»
«(...) Le motivazioni per cui dei giovani ricercatori si calino con entusiasmo in una etica della ricerca che ha molte affinità con quella con cui Weber ha interpretato le origini del capitalismo, possono essere molteplici. Dalla legittima aspirazione a redditualizzare le proprie capacità e i propri successi, al desiderio di condurre le ricerche in modo autonomo. Al di là di quale delle due motivazioni sia prevalente, il fatto non può non sollecitare l'attenzione di chi è interessato al governo della ricerca.
Il problema che pone uno schema di questo genere, che si adatta con facilità alle esigenze di un mondo in cui è dominante il paradigma del mercato, è se ricerche diverse da quelle che forniscono aspettative di esiti commerciali potranno trovare facilmente udienza sul mercato.
A mio parere si tratta di un nodo pretestuoso, in quanto sconta il mercato come un semplice algoritmo che confronta valori economici, senza tener conto che in esso si sviluppano relazioni basate su aspettative, ritualità, comportamenti non sempre riducibili ai valori economici. E non a caso mentre Puco & C., affidano la fortuna della loro ricerca sulla longevità alla Centagenetixn, Brunella Franco che sviluppa invece ricerche sulle "malattie orfane", quelle malattie talmente rare che nessuna casa farmaceutica inserirebbe nei propri programmi di ricerca, si rivolge alle Fondazioni. In altre parole, in base al tipo di ricerca, si potranno sviluppare mercati paralleli. Quello che rimane costante per l'accesso al mercato, sia esso quello delle utilities o quello delle fondazioni, è che il metro del paragone è il successo della ricerca.»
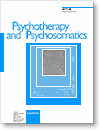
![]() Editoriali
di Psychotherapy and Psychosomatics
Editoriali
di Psychotherapy and Psychosomatics
il testo può essere chiesto allo Staff
della Fondazione Bassetti ( è in formato PDF: per leggerlo è necessario avere installato il programma "Adobe Acrobat Reader").
«The issue of conflict of interest is attracting increasing attention in medical journals. The notion of conflict of interest is widely used but may entail different meanings. Margolis distinguishes between conflicting interests and conflicts of interest. The former occur in any situation where competing considerations are presumed to be legitimate. Conflicts of interest, on the other hand, are characterized by individual occupying dual roles which should not be performed simultaneously. Because of the potential for abuse, performing both roles at the same time is considered to be inappropriate. Which roles? For instance, being a researcher and holding a financial interest in an area related to the research one is involved in. Despite the growing interest, however, the current debate on conflict of interest in medicine seems to fail to grasp its basic components. Such components emerge from a proper historical consideration of the debate, which may be divided into 3 stages. (...)»
E' disponibile anche la traduzione in Italiano
. [27 agosto 2001]
«La sorte di una delle più importanti ricerche sulla psicoterapia dei disturbi da panico è indicativa del grado di ostracismo vendicativo che tocca a chi non si adegua alle direttive del potere. Il pericolo è ovvio. La comunità scientifica si priva di una riserva di esperti disinteressati, che potrebbero essere consultati dagli organi legislativi del governo sulla sicurezza ed efficacia di trattamenti, sui rischi delle sostanze chimiche e sulla non-nocività di tecnologie. Costoro trovano sempre maggiori difficoltà a trovare finanziamenti per la ricerca e ottenere visibilità ai convegni e sulle pubblicazioni. Il recente scandalo riguardante la corruzione della FDA (l'agenzia governativa degli Stati Uniti preposta al controllo sui farmaci), è un chiaro esempio di questo pericolo. Non è che gli esperti disinteressati siano una specie estinta, come le agenzie vorrebbero farci credere. Il fatto è che essi vengono emarginati da chi controlla gli interessi delle multinazionali dentro le istituzioni pubbliche.»
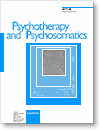 L'editoriale di Sheldon
Krimsky per il numero di maggio-giugno 2001 (vol. 70, n. 3, 2001) di
Psychotherapy and Psychosomatics: "Journal Policies on Conflict of Interest:
If this Is the Therapy, What's the Disease" [in English]
L'editoriale di Sheldon
Krimsky per il numero di maggio-giugno 2001 (vol. 70, n. 3, 2001) di
Psychotherapy and Psychosomatics: "Journal Policies on Conflict of Interest:
If this Is the Therapy, What's the Disease" [in English]
il testo può essere chiesto allo Staff
della Fondazione Bassetti ( è in formato PDF: per leggerlo è necessario avere installato il programma "Adobe Acrobat Reader").
E' disponibile anche la traduzione in Italiano
. [27 agosto 2001]
«Il conflitto può sorgere in tre modi: nella scelta delle domande da porsi nella ricerca, nel riportare i risultati della ricerca con "bias", e nella percezione che il pubblico ha della scienza. (...) Alcuni editori di periodici temendo di perdere credibilità, hanno cercato rimedio, chiedendo agli autori di rivelare le loro fonti di finanziamento. Fava è favorevole a questa strategia, come "primo passo essenziale per gestire la contaminazione del conflitto d'interessi nella ricerca", ma si domanda quanti periodici condividono questa posizione. (...) Io penso che i lettori, i recensori e i direttori debbano essere informati sull'origine dei finanziamenti delle ricerche degli autori di articoli su argomenti di pertinenza della pubblicazione. (...) Come nota Fava, il problema dell'integrità della scienza dipende, anche se non esclusivamente, dall'"author disclosure" di conflitti d'interessi.»
Si veda, a riguardo, l'editoriale del numero del 23 agosto 2001 di Nature (sopra, in questa pagina)
![]() Gli articoli dell'Economist
del 19 maggio 2001
Gli articoli dell'Economist
del 19 maggio 2001
«"SCIENTISTS at the McDonald’s Centre for Obesity Research suggest that eating a hamburger a day actually reduces cholesterol levels." Well, we made that up. However, this kind of company-backed research is becoming more common, and is undermining the fragile trust in science held by a public that has been fed a few too many whoppers.»
«Never look a gift horse in the mouth, goes the adage, and the University of Nottingham, in England, certainly did not. Last winter, when British American Tobacco (BAT) offered the university £3.8m ($5.4m) to finance a centre for research on business ethics, with no strings attached, the university gratefully accepted. One of its academics, however, did not acquiesce so readily.»
![]() Articolo di Annals
of Internal Medicine del 5 febbraio 2002 [in English]
Articolo di Annals
of Internal Medicine del 5 febbraio 2002 [in English]
| Correlazione |
|
![]() Articoli di
quotidiani italiani
Articoli di
quotidiani italiani
Chi sono i cosiddetti "esperti indipendenti"? C'è da scandalizzarsi alla notizia che alcuni dei massimi esperti italiani, da Edoardo Boncinelli e Renato Dulbecco, per finire a Leonardo Santi, sono consulenti della Novartis? E' sorprendente che una grande multinazionale come la Novartis si avvalga delle competenze di scienziati e ricercatori di questo calibro?
| Correlazione |
|
|
«Scienziati compiacenti che dimostrino che qualsiasi veleno è innocuo si trovano sempre, racconta il Wall Street Journal. (...) "Negli anni precedenti, quando le compagnie del tabacco avevano bisogno della scienza per sostenere le proprie cause legali, dovevano assumere in proprio i ricercatori" dice Jay Gourley del Public Education Center. "Ora c'è un febbrile settore di consulenti che fa il lavoro per te".»
| Correlazione |
|
Il tema del conflitto di interesse «è stato al centro di una ricerca svolta da due sociologi della scienza dell'Università di California e della Tufts University: per la prima volta in ambito scientifico viene analizzato il tanto discusso "conflitto di interessi" che però questa volta non interessa i politici ma gli scienziati. I due sociologi hanno valutato oltre sessantamila articoli scientifici per appurare se i loro autori dichiarassero il loro eventuale coinvolgimento finanziario nella ricerca in oggetto: ad esempio, possedere azioni di un'azienda direttamente interessata a un particolare risultato, esserne consulenti, aver ricevuto finanziamenti di qualsiasi tipo e via dicendo. I risultati indicano che appena l'1% degli autori denuncia espressamente di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, contro una stima che dovrebbe realisticamente avvicinarsi a una conflittualità di circa il 25%.
(...)
Il problema del conflitto di interessi è fondamentale nella ricerca biomedica, in cui l'efficacia di un farmaco potrebbe essere sopravvalutata da uno sperimentatore legato finanziariamente all'industria, come ha riconosciuto con rigore il New England Journal of Medicine scusandosi con i propri lettori per aver pubblicato valutazioni comparate su nuovi farmaci viziate dal conflitto di interesse degli autori degli articoli. Anche questa è una dimensione etica della ricerca che, per fortuna, comincia a farsi strada tra le riviste scientifiche.»
| Correlazione |
|
«(...) l'Economist solleva il problema del "conflitto d'interesse" nella ricerca.
Forse non è neppure paradossale che a farlo sia la voce più convinta ed estrema del libero mercato. D'altra parte, il settimanale britannico non propone di abolire i finanziamenti privati. Propone un po' di trasparenza: i ricercatori dovrebbero rendere pubblica la lista dei loro finanziatori, ad esempio quando pubblicano un lavoro su una rivista scientifica. Non è tutto qui, potremmo obiettare: ma certo sarebbe un bel primo passo sapere a quali interessi materiali risponde quanto affermato da alte cattedre...»
«L'industria paga chi la ripaga: il sapere per il sapere è al di là dei suoi interessi, se non come alibi, ma gli alibi, in questo caso, resteranno sempre sottopagati.»
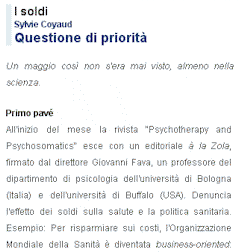 Sylvie Coyaud, "Questione
di priorità (un maggio così non s'era mai visto, almeno nella scienza)", Golem
[www.enel.it/it/enel/magazine/golem/], 5 giugno 2001:
Sylvie Coyaud, "Questione
di priorità (un maggio così non s'era mai visto, almeno nella scienza)", Golem
[www.enel.it/it/enel/magazine/golem/], 5 giugno 2001:«È ora per gli onesti di raggiungere il popolo di Seattle, scrive all'incirca Giovanni Fava [ndr: autore dell'editoriale pubblicato sulla rivista "Psychotherapy and Psychosomatics" (vol 70, n. 1, 2001), citato sopra].
(...)
Sul sito Internet del "British Medical Journal" --(...) uno dei migliori mensili della categoria-- si svolge un referendum. Il direttore editoriale Richard Smith è anche professore di giornalismo medico all'università di Nottingham: non gli piace che il suo ateneo abbia accettato un omaggio - 3,8 milioni di sterline, mica paglia - dalla British American Tobacco. Teme che si finisca con insegnare che "Un pacchetto al giorno toglie il medico di torno"» (per inciso, chi volesse ripercorrere le vicende che hanno recentemente coinvolto le multinazionali dell'industria del tabacco, può vedere il Percorso "Caso Tabacco"
)
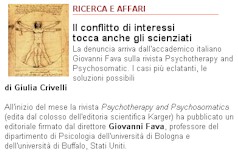 Giulia Crivelli, "Il conflitto di
interessi tocca anche gli scienziati", Il Sole 24 Ore on-line,
sezione "Cultura" [sul sito del Sole 24 Ore], 8
giugno 2001
Giulia Crivelli, "Il conflitto di
interessi tocca anche gli scienziati", Il Sole 24 Ore on-line,
sezione "Cultura" [sul sito del Sole 24 Ore], 8
giugno 2001«La denuncia arriva dall'accademico italiano Giovanni Fava sulla rivista Psychotherapy and Psychosomatic.»
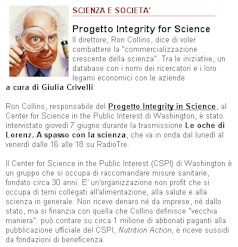 Giulia Crivelli, "Progetto Integrity for
Science", Il Sole 24 Ore on-line [sul sito
del Sole 24 Ore], 8 giugno 2001[27 agosto 2001]
Giulia Crivelli, "Progetto Integrity for
Science", Il Sole 24 Ore on-line [sul sito
del Sole 24 Ore], 8 giugno 2001[27 agosto 2001]«Il progetto sta anche pubblicando un "Integrity database", che rientra nel Progetto Integrity in Science, e si occupa (anzi, "si preoccupa", come dice Collins [ndr: direttore del progetto]) della commercializzazione crescente della scienza, del fatto che le imprese stiano arricchendosi grazie ai risultati della ricerca scientifica e stiano quindi cercando di controllarla sempre di più.
Il database consiste in migliaia di nomi di scienziati che hanno una qualche forma di legame economico con aziende. Viene indicato in quale centro di ricerca lavorano e quali sono questi legami ogni volta che sia possibile documentarli. Se il Progetto non riesce a trovare una documentazione accurata, non mette gli scienziati nell'elenco. Come dire: "Non possiamo garantirne l'integrità".
Collins è convinto che ogni volta che delle aziende mettono sotto contratto scienziati che lavorano nelle università, l'opinione pubblica e la stampa abbiano il diritto di essere informati di questo rapporto, perché può influire sul tipo di ricerca che viene effettuata. E' importante, in altre parole, capire se viene fatta ricerca per guadagno personale o se viene fatta nell'interesse collettivo, oppure se viene fatta per entrambi gli scopi.»
Intervista a Ron Collins, direttore del progetto "Integrity in Science", fatta in giugno 2001 dalla trasmissione di Radio 3 (Rai) "Le oche di Lorenz: a spasso con la scienza" (il testo è tratto dalle pagine web della trasmissione, pubblicate in <http://www.radio.rai.it/radiotre/>) [29 settembre 2001]
Vittorio Bertolini: Il conflitto di interessi nella scienza è una conseguenza della modernità (6 ottobre 2001, intervento al Forum)
Correlazione «Nella società del capitale globale i "fatti" degli scienziati assumono direttamente valore economico. E dunque gli scienziati, inevitabilmente, vengno ad assumere in essa ruoli diversi. Ci sono ancora, non c'è dubbio, scienziati che nella loro classica torre d'avorio scrutano la natura con la testa fra le nuvole per carpirne disinteressatamente i segreti, ma sono sempre di meno. Appartengono ormai a una specie in via di estinzione, come il panda. La maggior parte, invece, si trova in qualche modo coinvolta in problemi di denaro. Prima questione: le ricerche costano, e costeranno sempre di più. Chi le paga, e a che scopo? Seconda questione: i brevetti. Cosa si può brevettare? Chi intasca le royalties? Quando si parla di soldi, in genere, gli scienziati si innervosiscono, quasi che si mettesse in dubbio la loro integrità morale oltre che la loro correttezza professionale. E' come se fosse un argomento sconveniente. Ma possiamo ben dire che c'è (o dovrebbe esserci) una differenza fra i ricercatori dipendenti o i consulenti di imprese private legati al segreto industriale e gli operatori degli enti pubblici di ricerca che dovrebbero rispondere dei loro programmi alla collettività che li finanzia, o per lo meno concordare con i suoi rappresentanti le scale di priorità da rispettare. Chi può negare che i primi hanno come dovere contrattuale quello di massimizzare i dividendi dei propri azionisti e i secondi, come minimo, dovrebbero attenersi alle norme deontologiche mertoniane dell'universalismo e del comunitarismo? Come si fa a metterli insieme, in una categoria ideale al disopra delle parti come se fossimo ancora tutti nei panni dei fondatori della Royal Society?»
«La pretesa di giudicare a furor di popolo che cosa è vero (per esempio se esista un effetto concerogeno delle radiazioni elettromagnetiche o dei prodotti transgenici), ignorando i dati scientifici o cercando di svalutare personalmente coloro che li espongono, non rientra nel campo della democrazia, ma della demagogia (dal greco demos, popolo e ago, conduco, trascino).»
«L’opacità può essere funzionale a chi rappresenta grandi, in qualche caso giganteschi, interessi sul mercato. Non è interesse della scienza: la quale dalla trasparenza ha tutto da guadagnare, in termini di fiducia da parte delle opinioni pubbliche. (...) La crescita della conoscenza è di per sé espansione della libertà. Ma non c’è libertà --in questo caso la libertà che nasce dal sapere-- senza responsabilità, la responsabilità di fare delle conoscenze un uso socialmente equo ed eticamente corretto. Una responsabilità della quale nessuno può arrogarsi l’esclusiva, ma anche dalla quale nessuno può chiamarsi fuori»
| Links |
|