Venerdì 24 ottobre 2025, nell’ambito del nuovo appuntamento di Politiké, la Scuola Politica di Confcooperative Lombardia e Irecoop Lombardia, con la consulenza scientifica di Fondazione Bassetti, si è tenuto un dialogo tra il presidente Piero Bassetti e il presidente di Confcooperative Massimo Minelli. Di seguito, un report della conversazione, che prendeva il via dal titolo della giornata Geopolitica del conflitto e nuovi equilibri globali, che ha analizzato le trasformazioni dell’ordine mondiale alla luce dei conflitti contemporanei, con particolare attenzione al crescente peso geopolitico dei Paesi dell’Est e del Sud del mondo.
Piero Bassetti presidente della Fondazione Giannino Bassetti, riconosce in questi momenti di incontro occasioni fondamentali per riflettere sui cambiamenti del mondo contemporaneo. La generazione precedente viveva all’interno di un sistema regolato dalla logica dello scambio: ogni aspetto della vita, professionale e personale, era decifrato in termini di guadagno e perdita, conducendo al trionfo dell’economia su ogni altra attività. Oggi, invece, si sta entrando in un sistema diverso, nel quale le persone si muovono attraverso strumenti di comunicazione nuovi, differenti da quelli conosciuti fino a poco più di cinquant’anni fa. La Fondazione Bassetti, nata proprio dalla riflessione critica sugli effetti dell’innovazione, si pone come portatrice della narrazione e dell’analisi di questa rivoluzione. Il cambiamento nei sistemi di comunicazione, passati dai caratteri stampati a quelli elettronici e digitali, determina una riorganizzazione profonda, analoga a quella prodotta dall’invenzione della stampa. Non a caso, in Fondazione Bassetti questa transizione viene definita Gutenberg 2: così come l’invenzione della stampa generò eventi rivoluzionari con riorganizzazioni istituzionali, anche nella Chiesa cattolica, l’elettrificazione della comunicazione sta modificando il modo di rappresentare e vivere le relazioni. La prassi dello scambio viene progressivamente sostituita da una nuova modalità fondata sulla relazione.
Questa trasformazione comporta la necessità di coltivare relazioni, che possono essere di scambio o di cooperazione. Lo scambio lascia spazio alla relazione, che per sua natura si fonda sulla volontà comune, possedendo un intrinseco presupposto cooperativo. Nella politica mondiale, tuttavia, la cooperazione è spesso trattata in modo superficiale, considerata un surrogato, soprattutto in un momento storico come quello attuale, caratterizzato da tensioni e dal predominio dell’uso della forza. Eppure, la rivoluzione digitale sta potenziando il ruolo della cooperazione: il mondo, lentamente e inesorabilmente, sembra orientato verso uno spazio dominato dalle relazioni e dallo spirito cooperativo.
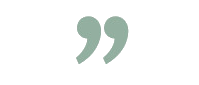
Da che parte sta andando il potere: da chi è in grado di scambiare a chi è in grado di gestire relazioni
Comprendere questo passaggio significa comprendere da che parte sta andando il potere: da chi è in grado di scambiare a chi è in grado di gestire relazioni. È il caso, ad esempio, degli Stati Uniti, che mostrano difficoltà proprio a causa della loro tradizionale concezione del potere come scambio; a differenza della Cina, che fonda la propria azione sulla logica relazionale. Come ricordato da Bettina Mottura, docente di Lingua e Cultura cinese presso l’Università degli Studi di Milano, esperta di linguaggi delle istituzioni e dei media nella Cina contemporanea, la Cina adotta spesso l’approccio del “win-win”, ossia la capacità di ritrovare il proprio interesse nell’interesse dell’altro o in un interesse generale. Un esempio significativo è la Nuova Via della Seta: un progetto di politica estera che, richiamando un passato comune e utilizzando un linguaggio condiviso, offre alla Cina legittimità internazionale e un destino comune con gli altri Paesi, pur mantenendo il proprio interesse economico. Dunque, attraverso una strategia discorsiva, la Cina propone una tradizione comune, su cui porre le basi per una futura cooperazione. Si tratta di una strategia fondata sulla relazione, come sottolineato da Bassetti, permesso da un Paese come la Cina, ancorato ai propri riferimenti ideologici e culturali.
Per Piero Bassetti, questa è la sfida del mondo moderno, che la Fondazione deve perseguire nella sua missione di riflessione sulla responsabilità dagli effetti dell’innovazione, anche sostenendo sistemi di formazione cooperativa come quelli messi in atto da Politikè. Quest’ultima permette di liberare la cooperazione dal ruolo marginale di surrogato nella logica dello scambio, rendendola protagonista in un mondo in trasformazione. La riflessione di Bassetti riporta al centro la persona e le connessioni, valorizzando i sistemi cooperativi come spazi vitali in cui dare forma e forza alle relazioni.
Massimo Minelli, presidente di Confcooperative Lombardia, apre il suo intervento riprendendo il tema della Cina proposto da Bassetti e affrontato dalla professoressa Mottura. La Repubblica Popolare Cinese, osserva, ha modificato il paradigma tradizionale degli scambi dominato dagli Stati Uniti, orientandosi verso un modello basato sulle relazioni, talvolta anche in forme di neocolonialismo, ma secondo una logica del “win-win”: un approccio collaborativo che riconosce le ragioni del proprio interesse nell’interesse del partner o della collettività.
Come Bassetti, Minelli sottolinea l’importanza di connettere, in un mondo in rapido cambiamento, il globale con il locale: l’Europa con le regioni, i territori e le comunità. Il regionalismo, afferma, rappresenta il nuovo terreno su cui investire per il futuro. In questo sistema è necessario giocare un ruolo attivo nel cooperare — prima ancora della Cooperativa — come paradigma d’azione in un mondo in cui il cambiamento non è più l’eccezione, ma la regola.
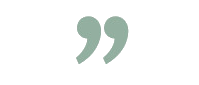
La cooperazione, tuttavia, sta mutando: il modello tradizionale, centrato sul capitale e sul mercato, deve oggi porre al centro la persona, la comunità e le relazioni
La cooperazione, tuttavia, sta mutando: il modello tradizionale, centrato sul capitale e sul mercato, deve oggi porre al centro la persona, la comunità e le relazioni. Come ha ricordato anche Bassetti, la cooperazione deve passare da ruolo marginale a ruolo centrale. Il mondo contemporaneo ha bisogno di cooperazione: accanto alle transizioni digitale e ambientale, serve una transizione cooperativa. Solo attraverso la cooperazione, la collaborazione e la relazione sarà possibile governare la complessità del presente.
L’Europa ha iniziato a riconoscere questa trasformazione, cercando di coniugare l’economia sociale con quella di prossimità. L’economia sociale, infatti, è un sistema di attività economiche incentrate sull’uomo e su finalità sociali e ambientali, comprendendo cooperative, imprese sociali, associazioni, fondazioni e società di mutuo soccorso. Si fonda su un mercato che genera profitto non solo di tipo economico, ma anche sociale e ambientale, riconoscendo che il mercato non è “a taglia unica”, ma deve necessariamente inglobare elementi non remunerativi. Esiste, infatti, una forma di mercato capace di redistribuire le ricchezze, senza annullare il profitto, ma rendendolo accessibile ad un maggior numero di persone.
Finora il mondo cooperativo è stato spesso considerato un correttivo ai limiti del capitalismo; oggi, invece, deve diventare protagonista, aprendo nuove formule di mercato radicate nei territori e nelle comunità. È fondamentale, inoltre, promuovere l’incontro tra le diverse forme di cooperazione, come sostenuto dal progetto Politikè che, pur mantenendo un ruolo prioritario per la cooperazione sociale, incoraggia la relazione con le altre realtà.
L’economia sociale, infine, implica anche una riflessione sul regionalismo. Le regioni sono chiamate a un nuovo protagonismo, declinando interventi nel welfare, nella cultura e nell’abitare, contrastando i processi di desertificazione sociale. Questo ruolo deve concretizzarsi attraverso l’uso dei fondi strutturali, investiti nelle persone e nella loro formazione. Tuttavia, poiché l’Unione Europea potrebbe rivedere le modalità di assegnazione di tali fondi, diventa necessario ripensare la struttura e la redistribuzione delle risorse regionali, per garantirne una reale centralità e un’operatività che sia concreta.
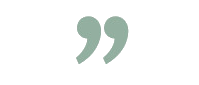
La consapevolezza del ruolo che la cooperazione può assumere nel sistema economico deve tenere insieme tre dimensioni: economia sociale, sussidiarietà e cooperazione
La consapevolezza del ruolo che la cooperazione può assumere nel sistema economico deve tenere insieme tre dimensioni: economia sociale, sussidiarietà e cooperazione. Si tratta di un sistema integrato, indispensabile anche per la competitività, che promuove una governance relazionale, orientata ad azioni condivise, abbandonando l’idea di vincitori e perdenti.
Confcooperative si colloca dentro questo sistema, come rappresentanza comune fondata su una relazione diretta tra potere e cittadino, contro ogni forma di isolamento. L’attenzione all’innovazione, nei processi e nei prodotti, resta centrale, insieme alla responsabilità nel gestirla. Le cooperative, radicate nei territori, devono contribuire a tenerli uniti in un organismo sempre più europeo e globale, consapevoli del proprio ruolo in Italia e capaci di proiettarlo, insieme all’Europa, nel mondo. Solo così sarà possibile costruire un’alternativa solida e pacifica, in cui ciascuno possa trovare il proprio protagonismo.
Le conclusioni del dibattito pomeridiano sono affidate a Piero Bassetti, che coglie l’occasione per richiamare l’attenzione su una problematica attuale: il voto. Lo scambio elettorale e il potere che esso determina devono essere oggetto di riflessione da parte del sistema cooperativo. I partiti, un tempo, altro non erano che “cooperative di votanti”, che si univano per contare di più. Oggi, però, i partiti appaiono in gran parte svuotati del loro ruolo originario: non basta più “contarsi”, ma occorre farlo secondo logiche nuove.
Il discorso politico entra così nel sistema cooperativo: anche fare politica presuppone cooperazione. Se il voto non tende a una sintesi, non può produrre un vero cambiamento nell’organizzazione del potere. È necessario, nella riflessione bassettiana, porre attenzione alla politicizzazione del Paese: una democrazia senza voto è un terreno in cui non si coopera. La funzione della cooperazione coincide con la funzione di politicizzazione del voto. Superata l’idea di uno Stato nazionale che concentra il potere in un’unica fonte d’autorità, il voto non deve ridursi a strumento di conquista del potere, ma deve diventare un esercizio di potere cooperativo. La politicità del discorso cooperativo non può esistere senza un legame profondo con la democrazia, intesa come sistema di relazioni, non di centralizzazione del potere.
















