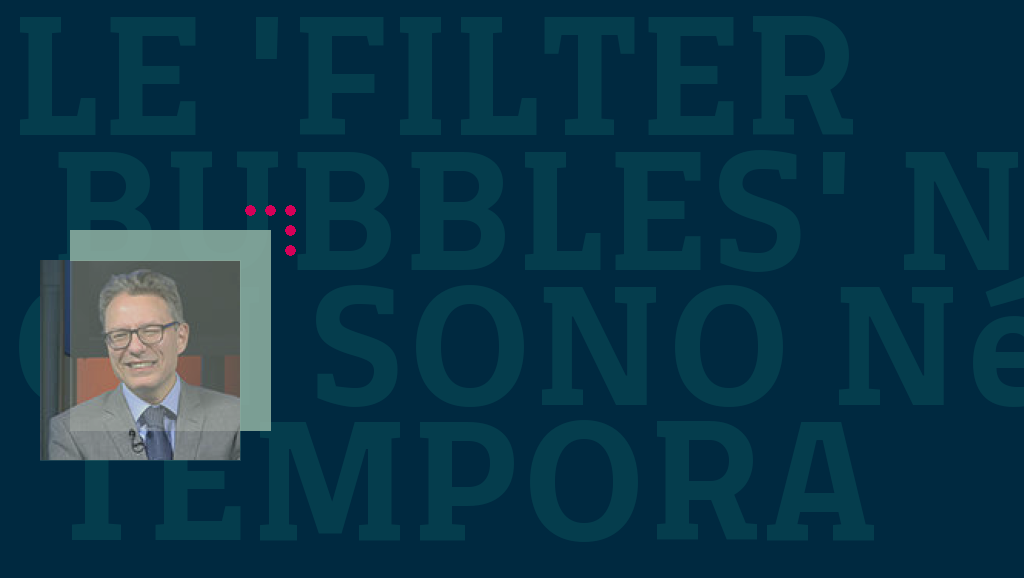Gabriele Giacomini indaga sul tema del rapporto tra democrazia e digitalizzazione della comunicazione, con una serie di interviste. Nel luglio 2017 abbiamo pubblicato le prime quattro (con il corredo del video), ora la serie prosegue.
Intervista a Luciano Floridi, 16 giugno 2017.
Secondo Floridi i social media portano per loro stessa natura all’effetto di inscatolamento delle nostre identità, e quindi del nostro mondo informativo. Alla base c’è un meccanismo economico. La pubblicità infatti è legata all’attenzione dell’utente. Per questo le piattaforme devono offrire ad ognuno qualcosa che gli interessa. O meglio, che già gli interessa, dato che è difficile creare un nuovo interesse. Il problema di questo meccanismo è che ci troviamo chiusi in scatole di informazione costruite a nostra immagine e somiglianza. Per promuovere un confronto più aperto e un’informazione di maggiore qualità ci sono diversi strumenti: l’educazione, soluzioni tecniche (limitare l’accesso a certe informazioni) e di mercato (rendere più conveniente fare buona informazione). La soluzione di certo non è la democrazia digitale, che rischia solo di aumentate la frammentazione e la polarizzazione. È invece la democrazia rappresentativa che può, allo stesso tempo, presentare le varie istanze e renderle compatibili le une con le altre.
Luciano Floridi
Luciano Floridi è professore di Filosofia ed etica dell’informazione presso l’Università di Oxford, dove è anche direttore del Digital Ethics Lab dell’Oxford Internet Institute. Le sue aree di ricerca sono la filosofia dell’informazione, l’etica dell’informazione e dell’informatica e la filosofia della tecnologia. Ha pubblicato più di 150 articoli scientifici e i suoi lavori sono stati tradotti in 16 lingue.
D. Online e offline: che rapporto hanno fra loro? Ha ancora senso una distinzione?
R. C’è stato un momento nella nostra recente storia in cui questa distinzione aveva senso. Abbiamo avuto un mondo in cui c’era l’online e l’offline, in cui si faceva il log in, in cui c’erano i modem. L’epoca dei modem era l’epoca in cui avevi la vita parallela delle informazioni online e delle informazioni offline. Si parlavano ma erano distinte. Usciamo dall’epoca del modem e queste due sfere sono ormai compenetrate. Oggi quando parliamo di informazione, nel senso di news, immediatamente pensiamo allo schermo piuttosto che ad un pezzo di carta. Diciamo che il cartaceo è stato sconfitto dal digitale in questo senso specifico di informazione. L’organismo dominante è un organismo ormai digitale, anche se l’analogico non è affatto finito. Oggi è inconcepibile che La Repubblica non abbia un sito web ma anche che rinunci al cartaceo. C’è una simbiosi fra digitale e analogico, un po’ come quando Roma conquistò Atene ma fu Atene a dare la forma intellettuale a Roma. Io penso che la versione cartacea arriverà ad un processo di polarizzazione. Da un lato avremo giornaletti regalati che valgono poco più della carta sui quali sono stampati, dall’altro lato avremo giornali costosi e di qualità come The Economist, che esce una volta alla settimana e dove si possono leggere riflessioni e studi. Questo è secondo me quello che l’organismo dominante sta generando per il cartaceo in questa simbiosi.
D. Che cosa ne pensa della disintermediazione? Quali conseguenze ha il digitale per il sistema dell’informazione?
R. È positivo poter fruire di canali disintermediati. Sarebbe però negativo se questo fosse l’unico modo per avere rapporti di tipo informativo. Se l’unico modo per avere delle notizie fosse attraverso i tweets e i post su Facebook di chi è stato coinvolto in qualche fatto non ne sarei felice, perché questo vorrebbe dire non poter avere un punto di vista terzo che metta insieme vari pezzi e che mi offra una visione complessiva, non di un solo frammento ma di tutto il mosaico. In questo senso, la mediazione è un bene quando è fatta bene. Ad esempio, io stesso sono un assiduo lettore dell’Economist perché trovo che la mediazione fatta dai giornalisti di questa redazione sia assolutamente di alto livello, e quindi godo sostanzialmente di un lavoro fatto da altri. Facendo un’analogia con il cibo, è positivo se sono in grado di cucinare da solo, però vorrei anche che qualcuno a volte cucinasse per me. Non è male andare in ristorante e mangiare qualcosa fatto da chi se ne intende. Quello che in questo periodo stiamo soffrendo è la trasformazione, il passaggio da un sistema completamente mediato a uno in cui può anche venire meno l’intermediazione dei giornalisti. Il mondo delle testate giornalistiche ma anche quello della televisione, quindi il mondo dei vecchi mass media, non è più protetto dal monopolio della mediazione e questo porta grosse sofferenze economiche, calo della pubblicità, ecc. Dato questo contesto, non sono sorpreso se molte delle testate giornalistiche stanno scivolando sempre di più nel gossip, nell’urlo, in notizie che vanno alla ricerca dell’estremo, perché purtroppo è solo attraverso l’estremo che sono ancora lette. Quando le persone comprano il giornale? Quando leggono che è scoppiata la terza guerra mondiale. Allora lo comprano, anche se poi si accorgono che in realtà è una sciocchezza, una notizia montata. Quello che io spero è che questa deriva porti infine all’implosione di questo meccanismo. Che le notizie sgangherate, l’urlo, la disinformazione vengano via via sempre più soffocate, che ci si renda conto che c’è bisogno di avere anche una buona mediazione e che sopravviva il meglio dell’informazione giornalistica.
D. A proposito di informazione digitale si parla di filter bubbles. Che cosa sono?
R. Il termine bubble può essere fuorviante perché come metafora è quasi simpatica. Chi è che non ama le bolle, le bollicine? Il termine ha quasi un retrogusto positivo. Invece ha origine dall’economia, dove le bubbles indicano momenti di forte espansione non giustificata (si pensi alla bubble nel mercato immobiliare oppure nel mercato finanziario). Il contesto semantico, quindi, ha a che fare con qualcosa che si espande e scoppia, e che quando ad un certo punto scoppia provoca crisi, recessione, inflazione. Un altro contesto semantico è quello della fragilità: le bubbles sono menzionate perché sono fragili, non perché sono robuste. Tuttavia, la temporaneità e la fragilità non sono caratteristiche adeguate a descrivere le filter bubbles. Per questo non amo la metafora delle filter bubbles, perché le due qualità che caratterizzano questa metafora non si applicano all’oggetto di cui si sta parlando. Non è una buona idea. È entrata nell’uso comune, ma è una cattiva metafora perché le bubbles di cui noi stiamo parlando, cioè le fake news, non sono né temporanee né fragili. Se fossero temporanee non ci preoccuperebbero. Riguarderebbero un momento, una situazione specifica che passerebbe presto, a cui ci potremmo sottrarre facilmente. Invece non è così. Inoltre non sono fragili, ma robustissime. Il genere di media che stiamo sviluppando porta per sua stessa natura all’effetto di inscatolamento delle nostre identità e quindi anche del nostro mondo informativo. Non perché ci sia un piano dietro, o perché ci sia un cattivo da qualche parte, ma perché è la logica stessa dei social media. È come il martello, che sembra fatto apposta per mettere chiodi. Così come la tara intrinseca del martello è quella di martellare, la natura intrinseca dei social media è quella di inscatolare. Il guaio è che ci troviamo inscatolati in questi box di informazione e che questi box non sono bolle né fragili né temporanee. La filter bubble è essenzialmente quello che ciascuno di noi, in maniera più o meno attiva e cosciente, si autocostruisce attorno. Ad esempio, sulla app della Bbc posso scegliere di mettere letteralmente dei filtri. Se non amo il calcio o lo sport, posso mettere un filtro che non mi fa più vedere le notizie sportive. La conseguenza è che con il collega universitario appassionato di rugby non posso più parlare, perché non ho neanche visto gli headline di quello che è successo nel mondo dello sport. Si capisce quindi in che modo ognuno si costruisce attorno delle scatole. Poi ci sono i grandi social media che, conoscendo i miei interessi, mi danno sempre di più quello che voglio. Allora io mi metto in una scatola e la scatola mi aiuta a stare sempre di più nella scatola. Il risultato finale è che pochissime persone hanno la consapevolezza di quanto non si sia assolutamente in contatto con l’altro. Il mondo che sta nell’altra scatola è totalmente impermeabile all’interazione.
D. Le grandi piattaforme social possono influenzare le nostre opinioni politiche? In che modo?
R. Si, certamente. La possibilità esiste da tempo ormai, dal momento in cui si realizza che su Facebook ci sono più di due miliardi di persone. Che ci sono centinaia di milioni di persone collegate ogni giorno su Facebook e che la piattaforma ha la funzione elementare di governare il flusso delle informazioni. Di fare apparire alcune informazioni in maniera più evidente, altre meno, in tempi diversi, in concatenamento diverso. È come se noi offrissimo le lettere dell’alfabeto, le a, le b, le c, e se tutto quello che facesse Facebook fosse quello di mettere le lettere in un certo ordine. Ma questa operazione si chiama scrittura. La narrativa è fondamentale, e lo sappiamo già ai tempi della Rai, quando c’era il palinsesto, ovvero l’azione di mettere in ordine le informazioni. Qual è la prima cosa con cui apre il telegiornale? Qual è l’ultima? Il modo in cui si ordina un giornale o un programma video è fondamentale. Per dirla in una maniera un po’ forte, è la rivincita della sintassi sulla semantica: la struttura con cui si ordinano le informazioni fa la notizia e il modo in cui ognuno assorbe il suo sapere sul mondo. Su questo Facebook, nel mondo dei social, ha praticamente un monopolio. Oggi è incredibile quante persone non si informino se non attraverso Facebook e Twitter. Si sente dire spesso “l’ho letto su Facebook”. É come se si dicesse “l’ho sentito al bar”, dove il barista decide quello che si può sentire, dove, quando. Un bar la cui sintassi è gestita dal barista.
D. Esiste il rischio che questo potere venga utilizzato per un impegno diretto in politica?
R. Queste grandi aziende non hanno interesse a fare politica. Al momento ci sono tutte le possibilità e gli strumenti, ma non c’è l’interesse. Anzi, si potrebbe dire che c’è un certo interesse a starne fuori, per via dell’interesse economico. È più conveniente dare tutto a tutti. Dare a chi vuole qualcosa quel qualcosa. Tu vuoi rosso, ti do rosso. Un altro vuole blu, ti do blu. Se vuoi rosso ti do più rosso e se vuoi blu ti do più blu. Facendo riferimento ai due principali partiti britannici, se sei laburista ti offro può contenuti laburisti, e se sei conservatore ti offro più contenuti conservatori. Per questo Facebook è propenso a mantenere il maggior disincanto nei confronti del politico, è l’anti-politica per definizione. Canale libero. Solo ultimamente Zuckerberg ha fatto mea culpa, dopo la vittoria di Trump ha detto che devono stare un po’ più attenti, soprattutto ai messaggi più violenti, all’incitazione al terrorismo. E fanno bene, ci mancherebbe. Questa è la direzione giusta. Il giorno in cui però questa mancanza di interesse nei confronti della politica finisse, per ragioni diverse, noi saremmo del tutto impreparati. Non c’è il minimo di salvaguardia nei confronti di un’eventuale deriva di Facebook in versione politica. Questa non è fantascienza, è semplicemente una possibilità davanti agli occhi di tutti. Pensare che sono dei bravi ragazzi non è una strategia.
D. Insomma, sugli interessi politici prevalgono nettamente quegli economici. Ed è un meccanismo di tipo economico che spinge le piattaforme ad offrire al proprio utente il mondo che a lui piace.
R. È assolutamente un meccanismo economico, basato sulla pubblicità. E la pubblicità è basata sulla gestione dell’attenzione dell’utente. Maggiore è il tempo impiegato dagli utenti sulla piattaforma meglio è. Quindi la piattaforma deve offrire ad ognuno qualcosa che gli interessa. O meglio, che già gli interessa. Infatti è difficile creare un nuovo interesse. Se a te piacciono i gatti, io ti darò più informazione sui gatti. Non mi metto a parlare di cani perché a te interessa il gatto, mica il cane. Il guaio è che questo meccanismo è di successo. In quale caso un meccanismo che funziona e che è efficace potrebbe venire smantellato per ragioni etiche? Non penso che vedremmo una cosa del genere. Questa natura delle piattaforme ricorda la storia dello scorpione che deve attraversare un fiume. Lo scorpione chiede ad un topolino se può passare il fiume sulle sue spalle. Il topolino è perplesso perché sa che lo scorpione potrebbe pungerlo, ma lo scorpione gli promette che si comporterà bene e il topolino accetta. A metà del fiume, però, lo scorpione cede e punge il topolino a morte. Infatti non poteva fare altrimenti, è nella sua natura anche se ciò implica la morte di entrambi. Fuori dalla metafora, spinti da motivi economici i social media creano scatoloni, filter bubble, ma non lo fanno intenzionalmente, quello è il meccanismo che li caratterizza.
D. È possibile uscire dal meccanismo delle scatole e promuovere un’informazione più aperta, un contesto sociale in cui è possibile confrontarsi con le ragioni dell’altro? Se si, come?
R. Secondo me dobbiamo distinguere quello che è reale da quello che è possibile. Realmente, al momento, il meccanismo di cui abbiamo parlato funziona largamente in maniera negativa, cioè inventiva il ricorso agli slogan, alla propaganda pubblicistica, è sostenuto da ragioni economiche. Ma non deve per forza essere così e potrebbe non esserlo. Potrebbe bastare poco per reinventare un meccanismo in cui gli incentivi non vanno in questa direzione. Io menziono spesso, per vivacizzare il dibattito, la possibilità di abolire la pubblicità online. Non credo che debba essere una proposta che le istituzioni dovrebbero realizzare, ma cito questa possibilità per chiarire che il meccanismo attualmente dominante non è un destino. Se non ci fosse la pubblicità on line cosa all’informazione online? Dovrebbero venderla. E se c’è vendita c’è competizione, se c’è competizione c’è anche un bombardamento di messaggi diversi. Oltre a chi ti vende contenuti sui gatti, che ti piacciono, potrebbe esserci anche chi ti propone cani o cavalli. E tu all’improvviso sai qualcosa di cani o di cavalli, non perché è un’informazione che stai cercando (l’individuo tende a cercare conferme), ma perché sei bombardato da diverse informazioni che magari non vuole neanche ricevere ma che comunque arrivano sul tuo tavolo. Al di là della fantascienza, un’idea più realizzabile è mettere un limite alla pubblicità. Stabilire una quota da non superare per ogni azienda. Si consideri che la pubblicità è una sorta di guerra fredda tra le aziende. Se un’azienda fa pubblicità ai suoi prodotti anche i concorrenti devono fare lo stesso. In questo modo il livello di quello che si spende in pubblicità è sempre molto alto. Questi meccanismi che sono diventati un po’perversi potrebbero essere ripensati. Sono ottimista sulla possibilità di farlo ma sono pessimista sulla nostra capacità di cogliere questa opportunità.
D. Oltre alla regolamentazione della pubblicità ci sono altri strumenti?
R. Ci sono alcuni altri strumenti. Nessuno di essi da solo è sufficiente, ma insieme possono fare la differenza, possono portare a un’ecologia dell’infosfera più sana. Uno è quello dell’educazione. Cioè insegnare alle persone ad essere un po’meno ingenue, ad informarsi da diverse fonti. Di nuovo l’opportunità è dietro l’angolo: non ci vuole molto a controllare la validità delle informazioni o una pluralità di informazioni. Io sono un po’scettico non sull’importanza dell’educazione, ma sulla vastità dell’impatto. Dove funziona, funziona benissimo. Il problema è che non funziona spesso. Per dieci bambini che imparano a comportarsi correttamente ce ne sono altri novanta a cui non arrivi. Spesso non si ha successo, ma ovviamente bisogna provarci, e magari quella minoranza che si salva andrà poi a gestire Facebook e Reuters. Formare l’intellighenzia non guasta. Poi c’è la soluzione più tecnica: censurare un certo tipo di informazioni dannose. Pensiamo al caso del copyright intellettuale. Quando per motivi economici il mondo della musica ha deciso di fermare il fenomeno delle copie illegali sono state intraprese azioni molto decise. Basta leggere i report di Google sui milioni di siti web oscurati al mese. Si può fare una cosa simile anche per ragioni sociali. Ad esempio, non credo sia giusto che il Ku Klux Klan abbia un sito web. In Europa blocchiamo già la propaganda nazista. Ma si può estendere questo controllo al terrorismo, all’incitamento alla violenza, ai temi sui quali come società siamo già d’accordo. Infine c’è la soluzione di mercato. Rendere conveniente un servizio migliore attraverso degli incentivi. La mia proposta sulla pubblicità è una delle strade possibili.
D. Secondo alcuni il digitale apre la possibilità a forme di democrazia diretta. Che ne pensa?
R. C’è un errore che abbiamo commesso e che era naturale fare. Un errore fatto anche da un grande liberale come John Stuart Mill, cioè l’idea che la democrazia rappresentativa sia in realtà un compromesso legato alla vastità del corpo politico nelle società moderne. Come scriveva Mill, se fossimo in un posto piccolo, dove è possibile parlarsi l’un l’altro, potremmo arrivare direttamente ad una deliberazione, e questa sarebbe una vera democrazia. Purtroppo però non possiamo farlo perché siamo in troppi, quindi dobbiamo scegliere dei rappresentanti. Ritengo che questo sia stato un errore, un’idea romantica inventata nell’800 che vede nell’Atene del quinto secolo un mondo che non è mai esistito, che si dimentica che Atene era piena di schiavi, piena di donne che non votavano e piena di stranieri che non avevano alcun diritto. Quando sono arrivate le tecnologie digitali e hanno reso possibile la democrazia diretta ci siamo accorti che l’idea della democrazia rappresentativa come “il meno peggio”, “il compromesso”, “se solo potessimo” è sbagliata. Infatti se mettiamo in moto la democrazia diretta resa possibile dalla tecnologia incontriamo il populismo. Si applica alla democrazia quello che accade già con Facebook e le news: dare a tutti quello che vogliono. Ad ogni gruppo diverso si offre qualcosa di differente, in base ai desideri dei membri. Allora non c’è più mediazione o compromesso perché ognuno vuole quello che ha chiesto. Non si ha più un contesto politico, ma un contesto di tipo agonistico, come in una partita di calcio. C’è il team che vince e il team che perde, non negoziano nulla. Si scende in campo, si gioca la partita e si vince o si perde. A questo punto si rischia di entrare in quella i padri fondatori della costituzione americana chiamavano la dittatura della maggioranza. Chi vince prende tutto ed entriamo in un contesto di polarizzazione. Credo che invece la democrazia rappresentativa sia il sistema migliore. È la quadratura del cerchio, dove troviamo sia la modalità di presentare le varie istanze sia però quella di renderle compatibili le une con le altre.
—————