Post
Human
[30 ottobre 2002]
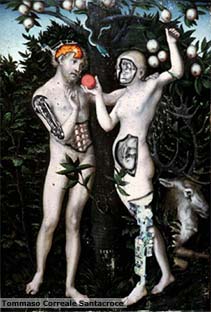  _____11 creature_____ _____11 creature_____
(Pagina di Tommaso Correale Santacroce)
Tra l'oggetto "essere" e l' "essere oggetto", tra
il costruire e il creare, tra il prevedibile e l'imprevedibile: un percorso per immagini
attraverso alcune figure chiave, espressione del desiderio dell'uomo di mettere mano alla
propria evoluzione, di immergere le mani nel magma della vita e formare qualcosa di
propria immaginazione.
|
|
Tecnoscienza e
Responsabilità
[12 ottobre 2002 ; agg : 30 ottobre 2002]
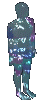  _____Da Homo
Sapiens a Homo Technologicus_____ [12
ottobre 2002] _____Da Homo
Sapiens a Homo Technologicus_____ [12
ottobre 2002]
L'ibridazione dell’uomo attraverso l’ingegneria genetica e le biotecnologie,
nonché l'evoluzione culturale verso le dimensioni di un mondo tecnologizzato: Vittorio
Bertolini, in una Rassegna stampa commentata, propone un percorso
sulla tematica "uomo, tecnologie informatiche e ingegneria genetica" che
sintetizzi il pensiero di Giuseppe O. Longo, il quale, per il quotidiano l'Avvenire,
affronta spesso la questione di come l’innovazione tecnico-scientifica si
debba rapportare a un concetto di responsabilità più ampio.
 _____Concezioni etico-culturali e rapidità dello sviluppo
tecnico-scientifico: le tesi dell' "adeguamento" e quelle del
"rallentamento"_____ [12 ottobre 2002 ; agg :
30 ottobre 2002] _____Concezioni etico-culturali e rapidità dello sviluppo
tecnico-scientifico: le tesi dell' "adeguamento" e quelle del
"rallentamento"_____ [12 ottobre 2002 ; agg :
30 ottobre 2002]
Federico Faggin, nell'intervista "Lo
sviluppo scientifico responsabile è il futuro della società" (News Italia
Press, 27 settembre 2002), sostiene che esiste un distacco tra scienza e società perché:
«(...) gli uomini non hanno saputo tenere il passo con lo sviluppo tecnologico. Il
rischio è che la tecnologia sia più avanti. Ma, se ci sono persone e movimenti che
ritengono che bisogna fermare la scienza, rallentarla, io non sono di questo parere: è
l'uomo che si deve adeguare. Certo, il tutto deve avvenire in maniera responsabile e con
un occhio alla trasformazione positiva della società.»
Faggin precisa che:
«Filosofia e scienza si intersecano nelle scelte che faccio, negli oggetti che faccio
oggetto di studio. Ho bisogno di elementi che mi diano il giusto stimolo intellettuale.
Inoltre, ho sempre cercato di svolgere gli studi su cose in cui credo e non perché
possano essere sfruttati male. Non lavorerei mai, per esempio per la difesa. Tutto deve
essere allineato con quello che penso, con i miei princìpi»
Giuseppe O. Longo sembra propendere, sia pur in un'ottica problematizzante, a favore
della posizione che ritiene necessario un rallentamento della corsa tecnologica (si veda  questo punto del suo saggio "Tecnoscienza e globalizzazione"). Nell’intervista che Margherita Fronte gli ha fatto
per la Fondazione Bassetti, egli afferma che: questo punto del suo saggio "Tecnoscienza e globalizzazione"). Nell’intervista che Margherita Fronte gli ha fatto
per la Fondazione Bassetti, egli afferma che:
«(...) c’è una responsabilità di chi inventa e diffonde le innovazioni (per i
possibili effetti che queste avranno su tutti), ma c’è anche una responsabilità di
chi rifiuta le tecnologie, perché così facendo ostacola i progressi che potrebbero
scaturirne. C'è però una dissimmetria: mentre l'adozione di una tecnica può avere
conseguenze irreversibili, non adottarla oggi spesso consente di adottarla domani, quando
ne siano più chiare le implicazioni»
(...)
Io auspico un rallentamento, che dovrebbe servire a capire in che direzione si sta
muovendo il sistema globale, a dare un orientamento in un’epoca in cui domina un
forte disorientamento»
Vittorio Possenti tocca la tematica del rapporto tra scienza, etica e tecnica
recensendo per l'Avvenire ("Un po' Jekyll e un po' Hyde: ecco
gli scienziati del 2000", 17 settembre 2002) il volume "Biologia domani: Dr
Jekyll o Mr Hyde?":
«Il curatore Jader Jacobelli, ha invitato una ventina di scienziati, giornalisti,
filosofi, medici a dare una risposta alla domanda se sia moralmente lecito compiere tutto
ciò che si può tecnicamente fare". Non diminuisce il rilievo della questione
l'evento per cui essa è risuonata numerose altre volte. Alcuni scienziati si mostrano
responsabili, altri direbbero volentieri: "Dateci fondi per ricercare e lasciateci
lavorare in pace".
(...)
Il fatto è che gli scienziati sono portatori di un bene di grande valore: la conoscenza,
che è sempre un fine buono e legittimo. Allora bisogna in tutto e per tutto fidarsi degli
scienziati?
(...)
L'etica della conoscenza non basta se ad essa non si coordina un'etica ancor più
fondamentale, che concerne l'uomo e la vita umana. Chiariamo: se ogni conoscenza è sempre
buona, non è vero che ogni sua applicazione lo sia parimenti. E' bene conoscere le grandi
risorse energetiche racchiuse nell'atomo, non certo sganciare una bomba atomica su
cittadini innocenti. Qui è l'impiego tecnico di una conoscenza, raggiunta in maniera
irreprensibile, ad essere immorale.»
Carlo Alberto Redi riflette sui nodi della scienza e dell'avanzamento del sapere in un
articolo scritto per La provincia pavese ("La ricetta di Redi: lasciamo
vivere la vita", 23 ottobre 2002):
«In un'epoca in cui tutti i valori sono omologati e gli aspetti del vivere quotidiano
sono visti attraverso il filtro dell'economia di mercato, un aspetto che i più vecchi di
noi dimenticano e i più giovani non considerano è che due sono i pilastri su cui si
regge uno stato etico-sociale (non importa come governato): la ricerca --e la condivisione
dei suoi risultati e cioè la formazione culturale dei cittadini-- e la salute.
La promozione di questi due valori non può essere omologata, cioè riducibile da vincoli
economici allo stesso livello assegnato dalle logiche di mercato ad altri valori, pena il
declassamento complessivo di una società e l'impoverimento della qualità della vita.
Cittadini in buona salute e culturalmente preparati possono, ovviamente, meglio agire e
meglio vivere in un mondo che si fa sempre più complesso, più inquinato e meno ricco di
risorse naturali. L'uomo (alcuni uomini), oggi è in grado di manipolare l'esistente e
l'etica che governa tali azioni non può più essere quella della negazione, non basta
più; è necessaria un'etica della responsabilità, che impone di investire nella ricerca
scientifica.
(...)
Il ritardo dell'azione educativa ed informativa, l'analfabetismo scientifico, le tragedie
ambientali e sanitarie causate dall'inefficienza, le dichiarazioni sul disinvolto impiego
di alcune tecniche (la clonazione umana), tutti questi fatti certamente concorrono a far
prevalere nel dibattito pubblico delle problematizzazioni di tipo etico, sociale e legale
delle implicazioni delle ricerche.
E così, un poco per ignoranza, un poco per rassicurare, a volte per non dispiacere al
Vaticano, i decisori politici tendono ad assumere posizioni di chiusura danneggiando la
ricerca.
(...)
Il caso clonazione mette in luce anche altri limiti della nostra società: i preconcetti e
pregiudizi ideologici. Si è sentito di tutto, decisori politici che disquisiscono sulla
natura dell'embrione, proposte strampalate (adozione degli embrioni criopreservati) ed
altre ancora, ma mai un barlume di approccio razionalistico al problema, con l'umiltà
necessaria di dare ascolto in primo luogo al ricercatore, allo scienziato.
Mai un tentativo di mettere in campo una chiara informazione scientifica, per permettere
ai cittadini di esprimersi liberamente sui vincoli, sulle limitazioni o sulle possibilità
applicative ritenute lecite. Così, mentre fecondatori assistiti con pochi scrupoli
ottengono le prime serate Tv, i cittadini vengono male informati e spaventati di ciò che
gli scienziati pazzi vorrebbero fare. La conseguenza è un ritardo incredibile su
possibili applicazioni terapeutiche (Parkinson, distrofie, diabete giovanile, ed altre
patologie).»
Paul Virilio, in "L'incidente del futuro", libro recensito da Lelio De
Michelis per La Stampa ("Tecnica
gigante uomo nano", 19 ottobre 2002), sostiene che:
«(...) ci aspetta un futuro senza "avvenire", svuotato di "senso",
privato di "direzione", spogliato di ciò che è semplicemente umano perché
ormai conquistato dalla tecnoscienza. Un futuro guidato dalla logica unilaterale e insieme
universale di una tecnica indifferente all'etica, alla politica, alla stessa volontà dei
cittadini che, essendo appunto educati e organizzati dalla tecnica per la tecnica, pensano
ormai in modo "naturalmente" conforme alla tecnica stessa.»
 La Rassegna stampa
commentata "Concezioni etico-culturali e rapidità dello
sviluppo tecnico-scientifico", a cura di Vittorio Bertolini, è dedicata ad
alcuni degli articoli sopra citati. La Rassegna stampa
commentata "Concezioni etico-culturali e rapidità dello
sviluppo tecnico-scientifico", a cura di Vittorio Bertolini, è dedicata ad
alcuni degli articoli sopra citati.
Alcuni commenti a partire dall'intervista a Faggin sopra citata
 Margherita Fronte: Margherita Fronte:
«Non credo che la questione possa essere lasciata alla buona volontà dei singoli. Penso
invece che occorra stabilire regole condivise. Le fughe in avanti saranno comunque
possibili, le "regole condivise" non impediscono a nessuno di compiere
esperimenti nella pratica, quando la tecnologia ha messo a disposizione gli strumenti.
Tuttavia le regole servono a collocare al di fuori della comunità scientifica i
"cani sciolti". Quando lo scorso agosto Rafael Valdés, medico messicano, ha
annunciato al convegno internazionale di trapiantologia di aver eseguito xenotrapianti di
cellule prelevate dalle isole pancreatiche di maiali in bambini, la comunità scientifica
ha reagito indignandosi e sottolineando che quella di Valdés è un'iniziativa "al di
fuori delle regole". In medicina esistono i comitati etici che devono approvare le
sperimentazioni (oltre a una serie di leggi). Perché un sistema analogo non potrebbe
essere applicato anche ad altri settori?»
 Corrado Del Bò: Corrado Del Bò:
«A me sembra che, in questo discorso di Faggin, si dia un'omologazione concettuale tra
scienza e tecnologia. I due concetti sono, invece, distinti: un conto è la ricerca
scientifica, un altro lo sfruttamento tecnologico dei suoi esiti. Che sia difficile tenere
distinti i due piani è un fatto, ma questo non implica che tale distinzione venga meno
anche sul piano logico. Si tratta di una distinzione che mi sembra rilevante, dal momento
che essa impedisce che la tesi sulla necessità del rallentamento dell'applicazione
tecnologia venga fatta coincidere con la tesi sulla necessità del rallentamento della
scienza, e che le persone che la sostengono vengano liquidate come oscurantiste.»
 Vittorio Bertolini: Vittorio Bertolini:
«Credo che Faggin voglia dire che i paradigmi etici sono rimasti fermi (o si muovono
molto più lentamente) rispetto a come si sviluppano le applicazioni della tecnoscienza.
Fino a Los Alamos lo scienziato scaricava sui tecnologi la responsabilità delle
applicazioni. Ora che la distinzione fra scienza e tecnica è molto più sfumata, il
tecnoscienziato non può più sfuggire a questa responsabilità. E infatti Faggin afferma
"Non lavorerei mai, per esempio per la difesa»
 Corrado Del Bò: Corrado Del Bò:
«Anche fosse vera la tesi sulla discrasia tra paradigmi etici e applicazione tecnologica,
resta, a mio parere, non chiaro nell'intervista a Faggin perché debbono essere i primi (e
non la seconda) a funzionare da variabile dipendente. Inoltre, il punto non è tanto
quello che farebbe o no Faggin (lavorare per la difesa oppure no), quanto piuttosto le
regole che debbono governare l'applicazione tecnologica; semplificando, non l'etica
individuale, ma l'etica pubblica.»
 Vittorio Bertolini: Vittorio Bertolini:
«Quando Faggin afferma che non collaborerebbe a progetti di riarmo, si riferisce a se
stesso ma, secondo me, pone una questione di etica pubblica. L'etica pubblica riguarda
sempre comportamenti individuali che però hanno una rilevanza pubblica.
La discrasia fra paradigmi etici e applicazioni della tecnoscienza (la distinzione fra
tecnica e scienza penso sia più di carattere storico-semantico che logico) appartiene al
modo in cui ambedue si modificano. La tecnoscienza opera nel contesto etico corrente,
produce però modificazioni nel modo di vivere che a sua volta modifica il contesto etico.
E' stata la scoperta degli antibiotici a liberalizzare i costumi sessuali e non
l'inverso.»
 Corrado Del Bò: Corrado Del Bò:
> Quando Faggin afferma che non collaborerebbe a
progetti di riarmo, si
> riferisce a se stesso ma, secondo me, pone una questione di etica
> pubblica. L'etica pubblica riguarda sempre comportamenti individuali
> che però hanno una rilevanza pubblica.
Io penso piuttosto all'etica pubblica nei termini posti da Sebastiano Maffettone (Etica
pubblica, Milano, Il Saggiatore, 2001, p. 25), e cioè come un "repertorio di
argomenti che, sulla base di alcune premesse metafisiche e politiche, fornisce un insieme
di giudizi valutativi di tipo filosofico sulla natura e gli scopi delle istituzioni
sociali". Riguarda più le regole, per così dire, che gli individui. Dal mio punto
di vista, ovviamente.
> La discrasia fra paradigmi
> etici e applicazioni della tecnoscienza (la distinzione fra tecnica
> scienza penso sia più di carattere storico- semantico che logico)
> appartiene al modo in cui ambedue si modificano.
Qui si apre un ginepraio di questioni... io credo che la distinzione "tecnologia /
scienza" sia una distinzione tra due concetti diversi, per quanto interrelati (direi
contingentemente interrelati), quindi una distinzione logica. L'unione di tecnologia e
scienza è un passaggio ulteriore, necessitato verosimilmente da interessi socioeconomici,
ma contingente. Penso, inoltre, che entrambe incidano sui paradigmi etici, ma penso che
vadano sottoposte a diversa valutazione le incidenze della tecnologia e quelle della
scienza.
Sono troppo ingenuo :-)?»
|
Back
Responsabilità
sociale dell'imprenditore
[12 ottobre 2002]
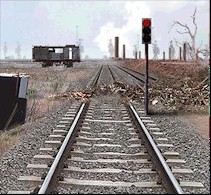  _____Quale impresa
per la sfida evoluzionista?_____ _____Quale impresa
per la sfida evoluzionista?_____
(Redazionale)
[segue dalla pagina degli Argomenti precedente]
Domenico Lanfranchi, nel suo Commento a un brano
di "Quale impresa per la sfida evoluzionista?", riprende il mito
platonico del Protagora per ribadire l’attualità di un problema vecchio come
il pensiero occidentale: quali rapporti debbono intercorrere tra la tecnica e la politica?
Secondo Lanfranchi, il punto è che "a fronte di un progresso tecnico scientifico che
procede ad un ritmo sempre più incalzante, usiamo ancora forme e strutture politiche
sostanzialmente vecchie di due secoli". Ora, i tentativi di innovazione effettuati
nel XX secolo a livello politico, conclusisi nelle tragedie dei lager e dei gulag, hanno
fatto sì che la democrazia sia in larga misura considerata un'istanza irrinunciabile, ma
non per questo si sono chiariti i modi attraverso i quali la si può garantire di fronte
alle altre istanze autonome (mercato e burocrazia) che cooperano alla governance
del mondo. Si chiede, allora, Lanfranchi: è opportuno che l'impresa si assuma
responsabilità politiche dirette, portando a compimento quello che, implicitamente, le
imprese più grosse fanno da tempo? Lanfranchi sembra assumere una posizione scettica:
«sempre più spesso i processi decisionali nelle imprese sembrano obbedire a criteri di
carattere meramente finanziario, più che ad una vera propria logica d'impresa: si è
verificata una sorta di capovolgimento dialettico per cui quello che in origine era solo
uno strumento per procacciare all'impresa le risorse necessarie alla sua attività, domina
oggi tutte le attività economiche e le imprese divengono meri strumenti asserviti
all'attività finanziaria. Non di rado è accaduto che attività produttive floride e sane
finissero sacrificate da spericolate operazioni finanziarie». Per questo, secondo
Lanfranchi, come sarebbe un errore trarre spunto da episodi di questo tipo per demonizzare
il mondo imprenditoriale tout court, sarebbe ugualmente un errore delegare alle
imprese compiti e funzioni politiche senza inserirle in un adeguato sistema di controlli e
contrappesi.
(12 ottobre 2002) |
Back |